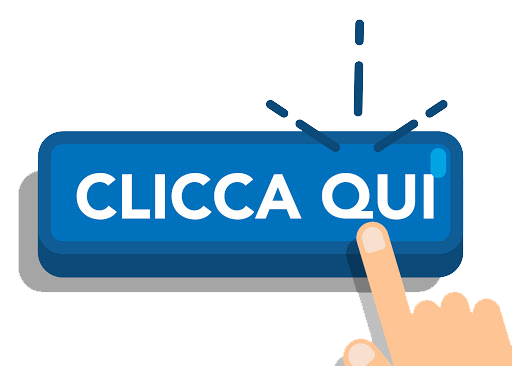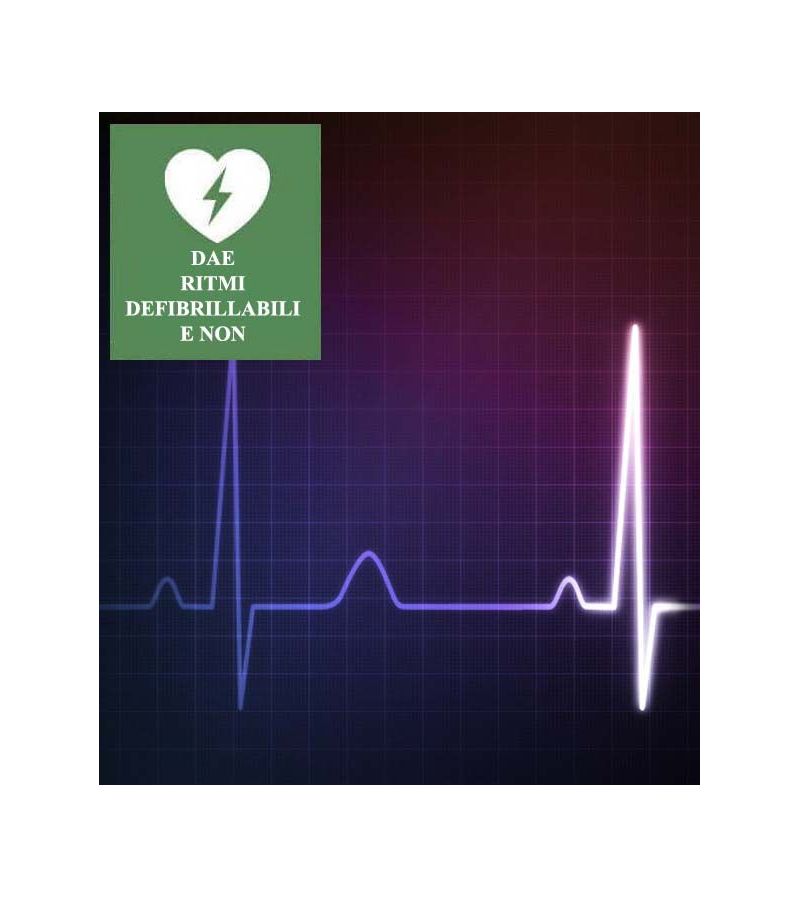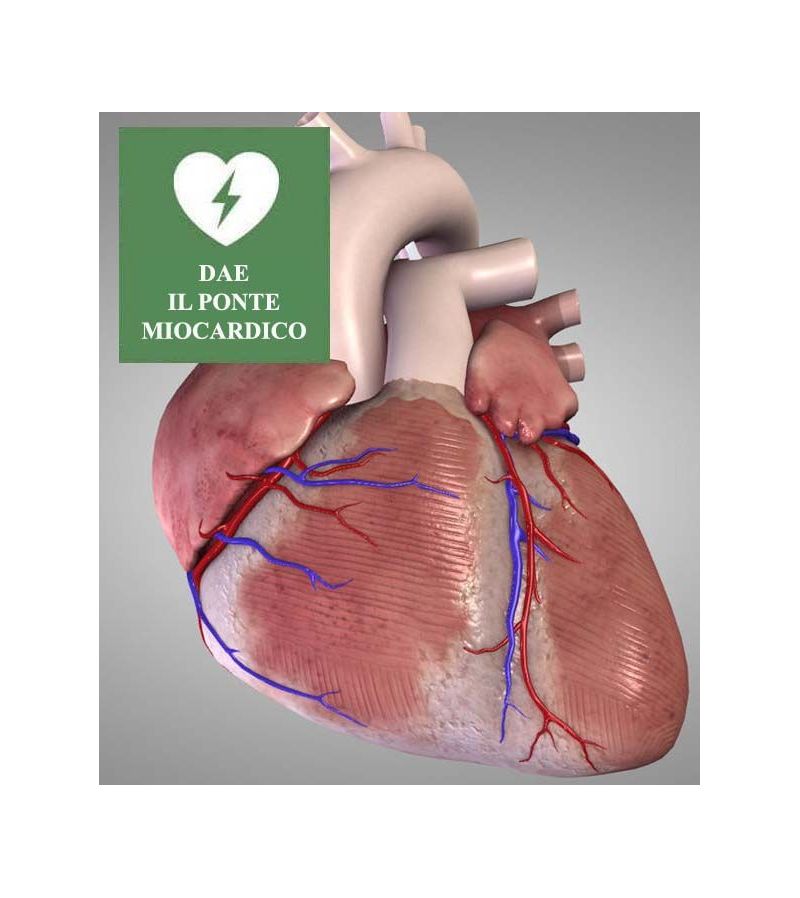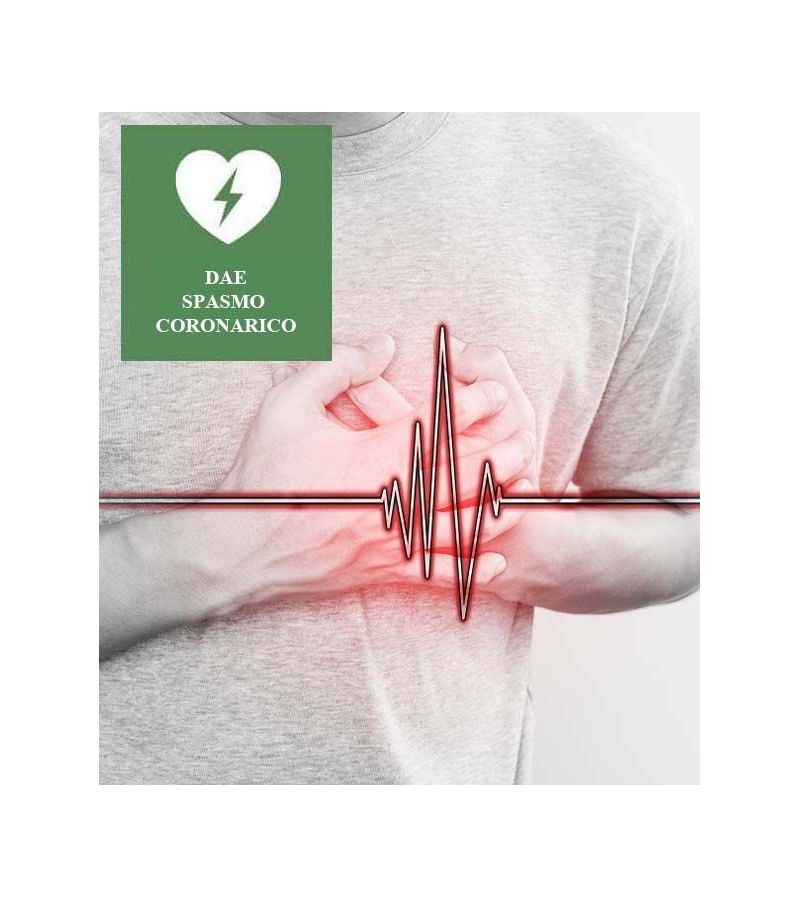Sindrome di Brugada

La Sindrome di Brugada è una malattia che colpisce maggiormente i giovani maschi in età adulta. Il difetto genetico è a carico di proteine che controllano l’ingresso di sodio nella cellula cardiaca. La mancanza di sodio, altera il funzionamento elettrico cardiaco dando vita ad aritmie che insorgono durante il sonno. La diagnosi viene effettuata con la valutazione dell’elettrocardiogramma e mediante somministrazione di farmaci che inducono specifiche alterazioni dell’elettrocardiogramma e con il test genetico.
Venne descritta per la prima volta nel 1992 dai fratelli Brugada che notarono subito un rischio maggiore di morte cardiaca improvvisa in assenza di una cardiopatia strutturale.
E’ una patologia genetica che coinvolge le strutture presenti sulla superficie delle cellule del cuore, causando un malfunzionamento e i conseguenti squilibri ed irregolarità nell’attività elettrica aumentando il rischio di insorgenza di aritmie fatali; possono inoltre manifestarsi aritmie, ritmo accelerato sincope, svenimenti e mancamenti, fino al fatale arresto cardiaco.
La genetica nella sindrome di Brugada
L’alterazione delle correnti ioniche nella sindrome di Brugada, ha un’origine genetica con trasmissione autosomica dominante: la prima mutazione della sindrome, è un’alterazione nel gene che codifica per la proteina che costituisce il canale del sodio. Una determinata mutazione genetica si presenta nel 30% circa dei pazienti colpiti, ma con lo sviluppo della ricerca genetica, si stanno descrivendo nuove mutazioni a carico di questo e altri geni.
Il cuore, nei pazienti affetti da Sindrome di Brugada, non vede la presenza di malformazioni ma resta affetto da patologie che causano fibrillazioni e aritmie del ventricolo.
La diagnosi, si ottiene escludendo le patologie a carico del muscolo cardiaco, riconducibili a questa sindrome.
Altri esami utili al rilevamento della sindrome di Brugada sono i test elettrolitici; si va a somministrare calcio per via endovenosa in una situazione controllata da appositi strumenti clinici.
L’esame si svolge in ambulatorio di fronte ad un’equipe composta da cardiologo, anestetista e un infermiere.
Caratteristica di questa malattia, è un’estrema variabilità di presentazione clinica ed elettrocardiografica. Infatti, l’elettrocardiogramma del paziente affetto può variare anche nell’arco di una stessa giornata, passando da momenti in cui il tracciato è nel complesso normale ad altri in cui può essere patologico.
Per la monitorizzazione elettrocardiografica, si procede all’esecuzione di un’infusione della durata di 10 minuti ed una successiva osservazione di ulteriori 10 minuti. Se il test dovesse risultare positivo saranno necessari ulteriori accertamenti e la degenza potrebbe prolungarsi. Si somministrerà un farmaco che ridurrà la funzione del canale di cui già si sospetta un ridotto funzionamento, accentuando lo squilibrio con le correnti ripolarizzanti.
Come eseguire la diagnosi
E’ fondamentale sottoporsi a visita cardiologica ed elettrocardiogramma. Quest’ultimo, nei soggetti affetti da Sindrome di Brugada, non è costante e per questo motivo la diagnosi della patologia potrebbe essere più difficoltosa. Se si ha un tracciato sospetto, andrebbe eseguito un ECG con holter per seguire l’andamento dell’elettrocardiogramma nel corso delle 24 ore. L’ecocardiogramma, permetterebbe di avere una visione più chiara rispetto a qualsiasi altro tipo di esame, in quanto riesce ad esaminare la struttura nel complesso con particolare attenzione a valvole, ventricoli, ipertrofia e ispessimento delle pareti. Per arrivare ad una definizione della sindrome è necessario che si manifesti anche uno tra i seguenti sintomi: Fibrillazione ventricolare documentata, Tachicardia ventricolare polimorfa, familiari con pazienti affetti e morte improvvisa in età inferiore ai 45 anni, inducibilità di tachicardia ventricolare con la stimolazione programmata allo studio elettrofisiologico, Sincope, Respiro agonico notturno.
Prima di stabilire una diagnosi di Brugada, vanno escluse quelle cause che possono determinare un simile aspetto nell’elettrocardiografico: le miocarditi, la displasia aritmogena del ventricolo destro, l’assunzione cronica di alcuni farmaci o semplicemente intensa attività sportiva.
L’alterazione elettrocardiografica, nella sindrome di Brugada, è secondaria a uno squilibrio tra le correnti ioniche entranti e uscenti dalle cellule cardiache, in genere causata da una ridotta funzione dei canali che conducono la corrente entrante del sodio. L’aspetto elettrocardiografico, è evidente per la presenza di una corrente uscente di potassio, rappresentata a livello del tratto di efflusso del ventricolo destro e non controbilanciata da quella del sodio.
La distribuzione non uniforme dello squilibrio tra le correnti ripolarizzanti e depolarizzanti, causa rischio aritmico per via della marcata diversità nella polarizzazione delle aree miocardiche vicine. Questo rende più facile la manifestazione di aritmie ventricolari polimorfe che possono sfociare in fibrillazione ventricolare e arresto cardiaco.
Lo studio elettrofisiologico
Non tutti i soggetti con sindrome di Brugada vanno in contro ad arresto cardiaco e di conseguenza morte improvvisa. Viene effettuata visita elettrofisiologica al fine di testare l’aritmia ventricolare in quei pazienti con familiarità per morte cardiaca improvvisa. Se dovesse esserci positività per le aritmie ventricolari pericolose, verrà consigliato il posizionamento di un defibrillatore impiantabile; posizionamento che è l’unica terapia considerata efficace.
Anche ai pazienti ‘asintomatici’, dopo essere stati sottoposti a visite elettrofisiologiche e in caso di positività ad aritmie ventricolari maligne, sarà impiantato un defibrillatore impiantabile.
Se il posizionamento del defibrillatore impiantabile dovesse essere inaccessibile o dovessero verificarsi aritmie ricorrenti, si seguirà una terapia farmacologica con chinidina, bloccante sia della corrente uscente di potassio sia della corrente del sodio, al fine di ridurre l’eterogeneità di polarizzazione e riduce il rischio aritmico.